 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Cesare
Bermani
"GUERRA
GUERRA AI PALAZZI E ALLE CHIESE...
"
Saggi sul canto sociale
PREMIO
OMEGNA 2003
SEZIONE SCAFFALE
pp.388 € 18,00
ESAURITO
|
Dal 1958 il gruppo torinese di Cantacronache – sulla scia
di una breve esperienza di Ernesto de Martino in Emilia nel
1951 – compie le prime approfondite ricerche sui canti
sociali italiani.
Dal 1962 in poi – grazie al decollo del Nuovo Canzoniere
Italiano e in seguito dell’Istituto Ernesto de Martino
– il movimento di riscoperta del canto sociale eserciterà
una profonda influenza su tutta quanta la cultura italiana,
dalla musica leggera ai cantautori, dalla musica colta alla
didattica musicale, dall’etnomusicologia alla storia (con
particolare riferimento alle origini della nostra oral history).
Sino ad allora ci si era domandati se davvero l’Italia
moderna avesse avuto un canto sociale, oltre le voci ormai rese
ufficiali dall’innodia risorgimentale, fascista, di partito
e dalle poche canzoni partigiane generalmente conosciute. E
i più ritenevano, fondando il giudizio su quanto era
sott’occhio, che ben povero era il nostro repertorio di
canti sociali, rispetto ad altri paesi, e che non valeva certo
la pena di correre dietro a fantasmi per trovarsi in pugno,
dopo un’inutile fatica, qualche misera strofa e qualche
retorico inno in più.
Le ricerche e le riflessioni di allora sul canto sociale hanno
praticamente ribaltato quanto la cultura ufficiale aveva teorizzato
in proposito; e oggi il nostro paese può contare su un
invidiabile corpus di canto sociale in raccolte, in pubblicazioni
a stampa e in dischi.
In un momento di nuovo grande interesse per il canto sociale,
questo volume ripropone i principali saggi di uno dei maggiori
protagonisti di quella battaglia culturale.
Il volume è corredato da circa quaranta partiture musicali. |
|
Cesare Bermani (Novara,
1937), promotore e collaboratore dell’Istituto Ernesto
de Martino (con sede attuale a Sesto Fiorentino), collabora
anche con la Società di mutuo soccorso Ernesto de Martino
di Venezia. Redattore e in alcuni periodi anche direttore
della rivista "il nuovo Canzoniere italiano", curatore
dei più importanti scritti di Gianni Bosio, è
stato tra i primi a utilizzare criticamente le fonti orali
ai fini della comprensione di passato e presente. Tra le sue
molte pubblicazioni: Pagine di guerriglia (4 volumi
in cinque tomi, 1971-’99), Una storia cantata (1997).
Per Odradek: Spegni
la luce che passa Pippo. Voci, leggende e miti della
storia contemporanea, 1996; Il
nemico interno. Guerra civile e lotta di classe in Italia
(1943-1976), 1997; Introduzione
alla storia orale (due volumi), 1999-2001.
 |
| Cesare
Bermani e Paolo Pietrangeli durante il récital
del 9 settembre alla Festa nazionale di Liberazione a
Roma. |
Indice
Introduzione
Note ai testi
I parte Analisi critiche
I canti sociali italiani
“La Marsigliese”: riflessi sul canto sociale del
movimento operaio italiano
Pierre Degeyter, contestato autore della musica de “l’Internationale”
Come nacque l’“Inno dei lavoratori”
L “Inno del sangue”
“Goarda là côla pianüra”. Un
canto sociale di non facile razionalizzazione
“La povera Rosetta”
“Fuoco e mitragliatrici”. Precisazioni su un canto
della Prima guerra mondiale
Le origini di “Bandiera rossa”
Lo “chansonnier” del comunismo italiano
L’«Ordine Nuovo» e il canto sociale
Come nacque “Fischia il vento”
La “vera” storia di “Bella ciao”
Alfredo Bandelli, “anarchiste en poète”
II parte Ricerche sul campo
Esperienze politiche di un ricercatore di canzoni nel Novarese
“Addio padre e madre addio”. La guerra cantata
Studi e ricerche sul canto di risaia: un primo bilancio
Lotta e comunicazione
Bibliodiscografia del canto sociale italiano
|
RECENSIONE
l’Unità, 7 dicembre 2003,
p. 21.
“Mondine o partigiani: chi cantò prima "Bella
ciao"?”,
Cos’è il “canto sociale”, come si
lega alla battaglia politica, all’idea di musica popolare.
Le risposte in un libro, splendido, di Cesare Bermani.
Franco Fabbri,
Perché la canzone
"ufficiale" della Resistenza è Bella ciao,
anche se i partigiani cantavano di più Fischia il vento?
E cos'è la "versione delle mondine", quella
inclusa nell'album ll fischio del vapore di Francesco De Gregori
e Giovanna Marini? Le risposte a queste e a molte altre domande
si trovano nella raccolta di saggi sul "canto sociale"
di Cesare Bermani, pubblicata da Odradek col titolo Guerra guerra
ai palazzi e alle chiese (un verso de L'inno dell'Internazionale,
sull'aria della Marsigliese, circa 1874).
Non preoccupatevi: le risposte verranno date anche qui, e il
bel libro di Bermani non è una raccolta di fatterelli,
buona per una serata di quiz in qualche vecchia Casa del Popolo.
Tutt'altro. Ma è lo stile dell'autore, la tenacia con
la quale rincorre e quasi sempre trova documenti e prove decisive,
a suggerire il paradigma indiziario per questi saggi storico-antropologici
rigorosi, densi, di lettura appassionante. Quasi sempre? Sì,
perché ad esempio la vicenda della "versione delle
mondine" di Bella ciao non è ancora conclusa, e
Bermami ci lascia in sospeso al termine del saggio, dopo aver
smontato e rimontato i fatti più o meno noti, e quelli
di cui solo pochi ricercatori sono a conoscenza. Ci torneremo
fra poco, abbiate fiducia.
Ma cos'è il "canto sociale"? Dai titoli si
intuisce che abbia a che fare con gli inni e le canzoni politiche
e con il canto popolare. Bermani usa questa espressione consapevole
delle contraddizioni insite nell'impiego disinvolto della categoria
del "popolare". Se popolare, per consuetudine etnomusicologica,
è sinonimo di contadino e di tradizione orale, allora
gli inni di lotta, dei quali è rintracciabile un originale
scritto, e che in buona parte sono nati dalla penna di intellettuali
urbani, non possono essere iscritti nella categoria del popolare,
se non in quanto il loro uso, la proliferazione delle modalità
esecutive e delle varianti, i metodi di ricerca di chi voglia
studiare questo materiale sono riconducibili a quelli tipici
della musica di tradizione orale. Allora Bermani ricorre a un
termine diverso per l'oggetto delle sue inquisizioni, e ci ricorda
che "il canto sociale è quindi, sin dalle sue origini,
fenomeno di frontiera tra culture ufficiali (sia dominante che
di opposizione) da un lato e culture popolari dall'altro, utilizza
a volte testi e musiche provenienti dalle culture egemoni (...),
a volte di produzione popolaresca (...), a volte interni alla
produzione popolare".
Insomma, in modo davvero esemplare Bermani ci mostra come per
studiare un insieme di musiche occorra prima di tutto riflettere
sulle categorie. E la categoria "canto sociale" riunisce
musiche di origini e caratteristiche disparate, riunite dall'uso
e dalla funzione. Parafrasando Gramsci si potrebbe dire: non
conta se questi canti siano nati sociali, ma se sono stati accolti
come tali. Difficile obiettare. Eppure, un tempo l'identificazione
fra popolare e contadino esercitava un'attrazione irresistibile
proprio sui ricercatori delle tradizioni, che al tempo stesso
coltivavano la canzone politica cercando di modellarla su quelle
tradizioni. Si discuteva se il canto popolare fosse di opposizione
in sé, o se il ricercatore e l'operatore di folk revival
dovesse privilegiare il repertorio che - si sarebbe detto allora
- sviluppava al massimo grado la coscienza politica delle masse.
Ecco, la storia della Bella ciao delle mondine inizia da qui.
Quando Giovanna Daffini, mondina e cantastorie, cantò
davanti al microfono di Gianni Bosio e Roberto Leydi una Bella
ciao nella quale ai noti versi del partigiano che ha "trovato
l'invasor" era sostituita la descrizione di una giornata
di lavoro delle mondine, non parve vero di aver rintracciato
l'anello mancante fra un inno di lotta, espressione della più
alta coscienza antifascista, e un precedente canto di lavoro
proveniente dal mondo contadino. Nonostante qualche incongruenza
e qualche sospetto, la versione venne accettata. E il Nuovo
Canzoniere Italiano nel 1964 partecipò al Festival di
Spoleto con lo spettacolo dal titolo Bella ciao. In quegli anni
dei primi governi di centro-sinistra si compie quella che Bermani,
riprendendo il concetto da Hobsbawm, chiama "l'invenzione
di una tradizione". Bella ciao, una canzone cantata durante
la Resistenza da sparse formazioni emiliane, e da membri delle
truppe regolari durante l'avanzata finale nell'ltalia centrale
viene sempre più frequentemente preferita nelle manifestazioni
unitarie a Fischia il vento, canto di larghissima diffusione
fra tutte le formazioni partigiane, riconosciuto nell'immediato
dopoguerra come l'inno della Resistenza. Fischia il vento ha
il "difetto" di essere basata su una melodia russa,
di contenere espliciti riferimenti socialcomunisti ("il
sol dell'avvenir"), di essere stata cantata soprattutto
dai garibaldini. Bella ciao è più "corretta",
politicamente e perfino culturalmente, anche se molti partigiani
del Nord non la conoscevano nemmeno. Era poi un canto delle
mondine, no?
No. Nel maggio del 1965 arriva una lettera all'Unità.
La scrive Vasco Scansani, da Gualtieri, lo stesso paese della
Daffini. Dice di essere lui l'autore della Bella ciao delle
mondine, e di averla scritta nel 1951, basandosi sulla versione
partigiana. Dice che la Daffini gli ha chiesto le parole, nel
1963. Allarmatissimi i ricercatori del Nuovo Canzoniere Italiano
interrogano Scansani e la Daffini: si rendono conto, nella confusione
delle testimonianze, che il mondo dei cantori popolari è
più complesso e contaminato di quanto non credessero,
che ci sono esigenze di repertorio, desiderio di compiacere
il pubblico, e di compiacere gli stessi ricercatori. Parte un
nuovo studio, si individuano tracce di Bella ciao in vari canti
popolari, non si esclude che fossero parte anche del repertorio
delle mondine: ma no, quella versione della Daffini è
posteriore alla Bella ciao dei partigiani. La storia, come ho
anticipato, non è finita: nel 1974 salta fuori un altro
preteso autore di Bella ciao, ma di una versione del 1934: è
Rinaldo Salvadori, ex carabiniere, che avrebbe scritto una canzone,
La risaia, per amore di una ragazza marsigliese che andava anche
a fare la mondina. Il testo, con versi come "e tante genti
che passeranno" e "bella ciao", glielo avrebbe
messo a posto Giuseppe Rastelli (futuro autore di Papaveri e
papere, politicamente "più nero che rosso"),
e la Siae dell'epoca fascista ne avrebbe rifiutato il deposito.
Il resto della vicenda lo potete trovare nel libro, splendido
e utilissimo, di Bermani. |
|
Premio
Omegna 2003, sezione Scaffale.
Dalla motivazione della giuria:
"Il ricco e denso libro di Cesare
Bermani, Guerra guerra ai palazzi e alle chiese,
pubblicato dalle Edizioni Odradek
di Roma in collaborazione con la Società di Mutuo Soccorso
Ernesto De Martino di Venezia nel marzo 2003, è un’organica
raccolta di saggi sul canto sociale divisa in due parti, la
prima di analisi critiche e la seconda di ricerche sul campo,
corredata da estese citazioni di parole e musica, da fitte
note e da quaranta pagine di bibliodiscografia. Ma il volume
non è solo una summa di riferimenti imprescindibili
per lo specialista erudito, bensì soprattutto un libro
di lettura entusiasmante per giovani e meno giovani appassionati
della nostra storia e una miniera per percorsi e approfondimenti
ulteriori per insegnanti, studenti, studiosi. Le lotte popolari,
sociali e politiche prima, durante e dopo la guerra antifascista
rivivono, per vividissimi e concreti scorci, attraverso le
canzoni e le loro storie, dall’Inno dei lavoratori
a Bandiera rossa, da Fischia il vento e Bella
ciao alla Ballata del Pinelli."
########
da Liberazione,
1 novembre 2008, p1/16
I borghesi cantavano "il Piave"
ma al fronte si cantava "Gorizia"
Scriveva
Marx nel libro primo del Capitale, a proposito di
macchine e grande industria: "Un sistema articolato di
macchine operatrici che ricevono il movimento da un meccanismo
automatico centrale soltanto mediante il macchinario di trasmissione,
costituisce la forma più sviluppata della produzione
a macchina. Quivi alla singola macchina subentra un mostro
meccanico, che riempie del suo corpo intieri edifici di fabbriche,
e la cui forza demoniaca, dapprima nascosta dal movimento
quasi solennemente misurato delle sue membra gigantesche,
esplode poi nella folle e febbrile danza turbinosa dei suoi
innumerevoli organi di lavoro in senso proprio".
La guerra industrializzata, questa industria del macello umano
specializzato, venne colta come un'estensione di questo sistema
di macchine senza centro e periferia, che poneva in crisi
qualsiasi lettura che muovesse dall'individuo e che dava la
sensazione di partecipare a un evento non voluto dai suoi
autori umani. Fu questa sensazione a influenzare massivamente
la visione che i soldati ebbero di se stessi e della realtà
circostante.
Scriveva, per esempio, Rudolf Bilding: "Sbaglia chi paragona
questa guerra a un'antica campagna in cui le volontà
degli avversari si fronteggiavano apertamente: in questa guerra
entrambi gli avversari giacciono sul terreno e solo la guerra
ha una propria volontà".
La grande guerra fu di trincea e - scrive padreva Agostino
Gemelli - "La vita di trincea, ad eccezione dei periodi
di azione difensiva (i bombardamenti) ed offensiva (gli attacchi)
è così monotona e scolorita che determina una
specie di restringimento del campo della coscienza. L'uniforme
paesaggio che si stende dinanzi alla trincea, limitato dalla
visibilità delle feritoie o dai fori praticati nei
muricciuoli delle ridottine e degli appostamenti, è
tale da rendere ancora più monotona la vita di trincea.
Il cannone ha distrutto ogni germe di vegetazione; tra la
propria trincea e quella nemica non vi è che un tratto
di terreno sconvolto, più o meno ampio, di là
e di qua i reticolati, paletti contorti, qualche straccio
che il vento agita goffamente. E' un deserto. Non un movimento.
Gli osservatori, le vedette, conoscono il terreno punto per
punto, in ogni minuzia. Un ramo d'albero smosso, una palata
di terra fresca, un sasso cambiato di posto sono avvertiti
come gravi novità. A quando a quando, nelle giornate
di tregua, romba d'un tratto un colpo secco di fucile che
desta, come per eco, altri colpi; a quando a quando il rabbioso
chiacchierare delle mitragliatrici. Poi di nuovo silenzio
di morte".
La guerra di trincea è anche l'invisibilita del nemico,
rendendo la terra di nessuno e la prima linea un mondo ignoto,
per cui al di là del reticolato tutto è perturbante.
Inoltre quell'invisibilità esasperava l'importanza
del senso acustico e sembrava rendere l'esperienza della guerra
particolarmente soggettiva e impalpabile. L'udito era infatti
diventato più utile della vista per cogliere e individuare
le fonti di pericolo.
Anche il rintanarsi del combattente fra e sotto la terra -
una terra divenuta un labirinto di cunicoli, silenziosi, bui,
in grado di fare perdere l'orientamento - veniva vissuta al
contempo come rifugio e minaccia permanente, svolgendosi nel
costante pericolo di cannoni e mortai che inducevano nei fanti
una sorta di terrore totale.
E quel po' di eroismo che qualcuno poteva inizialmente avere
avuto era stato seppellito da un lavoro monotono e continuo
da scavafossi e dal susseguirsi dell'allestimento dei trinceramenti
alle corvée e ai turni di guardia, effettuati da uomini
spesso tormentati dalla fame e sempre da pulci, pidocchi e
topi.
Infatti, come ebbe a dire quel grande disegnatore e grande
interprete della Grande Guerra che fu Otto Dix, che pure era
stato in precedenza accesamente interventista, «Pidocchi,
ratti, filo spinato, pulci, granate, bombe, cunicoli, sotterranei,
cadaveri, sangue, liquame, topi, gatti, artiglieria, sozzura,
pallottole, mortai, fuoco, acciao: ecco cos'è la guerra.
E' opera del diavolo".
C'era quindi molto ironia e rabbia nel cantare «Il general
Cadorna / ha fatto un'avanzata. / Ha preso tutti i topi /
che c'era in camerata».
Mentre l'inno per eccellenza di quel genere di guerra avrebbe
potuto essere questo altro canto: "La vita del militare
/ non ci può più dolorare / patimenti e tribolazion
/ e l'onore è sensazion.// E' una vita da maledetto
/ che costretti l'abbiamo da far / che immaginar 'n si sa.//
E dalle pulci siam mangiati /dai pidocchi tormentati/ ma 'i
pigliamo a centinaia / ma 'i nella camicia e nella maglia
/ e ogni luogo nel capel / li schiacciamo col martel.// Come
son grossi / han fino gli ossi /dal gran tormento tormento
/ e ben poco ci lascia dormir. // E fra topi e toponi / sono
i nostri amiconi / anche certo il barbagian. / Con lor noi
viviamo / e il rancio dividiamo.// E ciò che provvede
/ vogliamo mangiare /mangiar non possiamo / perché
troppa miseria c'è".
In una guerra di trincea, dove la libertà d'azione
era paralizzata dalla superiorità della potenza di
fuoco difensiva sulle truppe attaccanti e mitragliatrici e
barriere di filo spinato rendevano pressoché inespugnabili
le linee di difesa, gli Stati Maggiori si convinsero di potere
forzare quella situazione aumentando il fuoco offensivo delle
artiglierie, combinato con i gas e con l'offensiva di enormi
masse umane. Ma di solito anche pochi fucilieri nemici sopravvissuti
al tiro preparatorio d'artiglieria erano in grado di fare
terminare gli attacchi sul filo spinato. E anche se l'avanzata
avesse avuto successo "dietro ogni breccia praticata
nel sistema difensivo in questa guerra di trincea potevano
essere scavate e fortificate nuove linee, prima che la forza
attaccante riuscisse a spostare in avanti la propria artiglieria
su quel deserto di fango e rovine che essa stessa aveva creato".
Quei tentativi di forzare la situazione non fecero altro che
provocare immani macelli e aumentarono drammaticamente il
senso di distacco tra Stati Maggiori e loro truppe, dando
vita a più riprese a forme di ostilità reciproca.
«Il general Cadorna / è il capo dei briganti./
Ordinava ai suoi soldati /dicendo sempre "Avanti!"//
Bombe a man / e colpi di pugnal» recita una delle innumerevoli
strofette che avevano per mira lo Stato maggiore italiano.
E un'altra: «Sapete cos'ha fatto/ la nostra artiglieria?/
Ha massacrato tutta/ la povera fanteria// Bim bom bom / al
rombo del cannon». Infatti anche la propria artiglieria
era spesso per il fante il nemico più temibile e l'alleato
migliore di coloro contro cui si combatteva.
Lo spirito offensivo e aggressivo che avrebbe dovuto caratterizzare
il soldato, in una guerra divenuta difensiva da entrambe le
parti, che per di più sembrava non potesse vedere la
fine, lasciava inevitabilmente il posto ad atteggiamenti tesi
a ridurre l'ostilità reciproca.
Si sapeva che ogni colpo di mortaio, raffica di mitragliatrice,
scarica di fucileria avrebbe avuto una risposta. E quindi,
a dispetto degli Stati Maggiori, si faceva di tutto per evitarle.
Così il cannoneggiamento del mattino si limitava a
pochi colpi, e di solito indirizzati in certi punti delle
trincee conosciuti da entrambe le parti e quindi sgomberati.
Dopo alcuni mesi di guerra, Era ormai consapevolezza diffusa
tra i soldati di tutti gli eserciti belligeranti che essa
era ormai priva di scopi ed aveva triturato qualsiasi precedente
motivazione per combatterla.
Vi è una leggenda che può considerarsi il prolungamento
di questo stato d'animo:
"... in qualche punto tra le due opposte linee si trovava
un gruppo della forza di un battaglione (alcuni dicevano di
un reggimento) di disertori semi-impazziti provenienti da
tutti gli eserciti, alleati e nemici, che vivevano sottoterra
perfettamente in pace tra loro in trincee, rifugi e buche
abbandonati, donde emergevano la notte per saccheggiare cadaveri
e procurarsi cibo e bevande. Quell'orda di selvaggi visse
sottoterra per anni e infine si fece così numerosa
e rapace e irrecuperabile che fu necessario sterminarla. Osbert
Sitwell conosceva bene questa storia, e dice che i disertori
comprendevano francesi, italiani, tedeschi, austriaci, australiani,
inglesi e canadesi. Quegli essere barbuti, barcollanti nelle
loro uniformi lacere e rattoppate erano un mito creato dalle
sofferenze dei feriti come conseguenza delle angosce, delle
privazioni e dell'abbandono o esistevano davvero? E' difficile
dirlo. In ogni caso, la storia riscuoteva largo seguito tra
le truppe, che sostenevano che lo stato maggiore generale
non riuscì a trovare il modo di liquidare questi banditi
fino alla fine della guerra, e che infine dovettero liquidarli
coi gas" (Paul Fussel).
Questa leggenda suggerisce forse più di ogni altra
un sentire comune a molti fanti di tutti i fronti: che il
vero nemico di qualunque soldato è la guerra e non
sono i soldati nemici.
La vita di trincea faceva poi sentire lontani non solo i propri
Stati Maggiori ma anche la vita civile che si era lasciata
alle spalle e, vedendo sempre meno le proprie azioni come
parte di piani preordinati che avrebbero dovuto portare a
precisi risultati, i fanti furono tra l'altro assillati almeno
dal 1916 in poi dalla domanda: "Potrà mai finire
questa guerra?". Scrive in proposito ancora Paul Füssel:
"Non era necessario essere un pazzo o un visionario particolarmente
depresso per immaginare in tutta serietà che la guerra
non sarebbe mai finita e che sarebbe diventata la condizione
permanente del genere umano. La situazione di stallo e il
logoramento sarebbero continuati all'infinito, diventando,
al pari del telefono e delle macchine a combustione interna,
parte integrante dell'atmosfera ormai accettata dell'esperienza
moderna".
E il maggiore Pilditch, considerando gli avvenimenti sulla
Somme nell'agosto 1917, annota: «Entrambe le parti sono
troppo forti perchè per ora si possa giungere a una
conclusione. A questo ritmo chissà quanto durerà
ancora, Nessuno di noi vedrà mai la fine, e i bambini
che vanno ancora a scuola saranno chiamati a succederci».
Questo stato d'animo era diffuso su tutti i fronti.
Si aggiunga che nella guerra di trincea proprio di fronte
a te sta la trincea nemica, cioè «...la strana
terra in cui non potevamo penetrare, il "giardino oltre
il muro" dei nostri incubi» (S. Casson).
"Sentire" una presenza sconosciuta vicina senza
poterla vedere apre la strada alla più intensa proiezione
della propria paura.
Scriveva Emilio Lussu: «E' da oltre un anno che io faccio
la guerra un po' su tutti i fronti, e finora non ho visto
in faccia un solo austriaco. Eppure ci uccidiamo a vicenda,
tutti i giorni. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure
vedersi! É orribile! É per questo che ci ubriachiamo
tutti, da una parte e dall'altra».
L'invisibilità del nemico e la necessità di
autodifesa da ordini che appaiono e spesso sono insensati
spinge i soldati di ogni fronte a rivolgere la propria ostilità
verso ufficiali, stato maggiore, "patria". Da parte
sua lo stato maggiore vede in questa ostilità una cospirazione
e una volontà di non combattere, rese responsabili
dei propri errori di conduzione del conflitto.
Un macroscopico esempio di ciò fu rappresentato dagli
avvenimenti successivi alla rotta di Caporetto. Come mi ricordava
il fante Giovanni Armandola, "dopo un po' ci han messo
la fascia al braccio, ‘Brigata Foggia, traditori della
Patria'; e dopo un po' ci han messo uno per uno, ‘qui
bisogna andare al carreggio. Uno, due, tre... dieci, fuori;
uno, due, tre... dieci, fuori' [...]: il dieci ha lasciato
la pelle senza sapere il perché".
Ha scritto Mario Silvestri che nel periodo successivo a Caporetto
"l'Italia tenne il fiato sospeso: ecco perché
il nemico prevaleva! perché un pugno di rinnegati si
erano prestati alla parte di Giuda; e frutto del tradimento
era lo ‘sciopero militare'.
Al momento la spiegazione fu creduta, e con soddisfazione.
Molto più profondo scoramento avrebbe provocato la
denuncia delle cause reali della rotta di Caporetto: incapacità
di comandi, errori marchiani, disubbidienze , impreparazione
professionale, mancanza di addestramento. Se le vere cause
fossero state conosciute e pubblicizzate, poteva anche farsi
strada l'idea che il disastro fosse irreparabile".
In soccorso della menzogna arrivò allora anche E.A.Mario,
che con "La leggenda del Piave", scritta nel giugno
e completata nel novembre 1918, cioè a guerra finita,
sembrò volere perpetuare la leggenda del tradimento
a Caporetto, poiché la seconda strofa (poi soppressa)
iniziava: «Ma in una notte trista/ si parlò di
tradimento,/ e il Piave udiva l'ira e lo sgomento. / Ah! Quanto
gente ha vista/ venir giù, lasciare il tetto/ per l'onta
consumata a Caporetto…».
Non meraviglia quindi che i soldati cantassero così:
"Il Piave mormorava / calmo e placido al passaggio /puzzavano
li piedi di formaggio.// L'esercito marciava/ per raggiunger
la frontiera/ puzzavano li piedi di gruviera.// Muti restaron/
nella notte i fanti./Puzzavano li piedi a tutti quanti…".
Vera "invenzione di una tradizione", "La leggenda
del Piave" finì per imporsi a furia di essere
eseguita in celebrazioni ufficiali e riti collettivi.
Ma al fronte i soldati cantavano ben altro, strofe come queste:
"Maledetto sia Cadorna/ prepotente come d'un cane/ vuol
tenere la terra degli altri/ che i tedeschi sono i padron.//
E vigliacchi di quei signori/ che la credevano una passeggiata/
quando sentirono la loro chiamata / corsero a Roma e s'imboscar.//
E quei pochi che ci resteranno/ l'anno venturo verranno a
casa/ e impugneran la loro spada/ contro i vigliacchi di quei
padron// La Quadruplice malintesa/ che di pace non vuol sentire/
ma non sa cosa sia soffrire/ là sul Piave a guerreggiar.//
Dal governo siam malnutriti/ dagli ufficiali siam maltrattati/
i quattro Stati si son riuniti/ per distruggere la gioventù»
Notava ancora Mario Silvestri: «La vita in trincea aveva
favorito nella truppa in linea un fiorir di canzoni su tutti
gli aspetti della sua esistenza grama e pericolosa. Dalle
canzoni dei soldati le parole della retorica convenzionale
erano regolarmente bandite: niente Patria, Italia, Trento,
Trieste… Questi motivi riecheggiavano tanto più
intensamente quanto più ci si allontanava dalla zona
di combattimento; e il massimo di frequenza era raggiunto
dagli avanspettacoli e nei "cafés-chantants"
delle grandi città. Qui gran tripudio di bandiere,
il tricolore era sprecato: ballerine nei tre colori, strisce
tricolori, quinte e sfondi tricolori. E quanto più
lo spettatore si sentiva al sicuro, tanto più si spellava
le mani nell'applauso».
"La Leggenda del Piave" nasce e si afferma qui ,
non certo in zona di combattimento.
|
|
 |
 |
 |
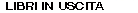  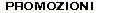  |
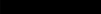 |
 |
 |
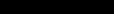 |
 |
| Odradek
Edizioni srl - Via san Quintino 35 - Tel e Fax. 067045 1413 |
|
 |
|